Andrea Fantini, “Un autunno caldo. Crisi ecologica, emergenza climatica e altre catastrofi innaturali”, Codice edizioni, Torino 2023
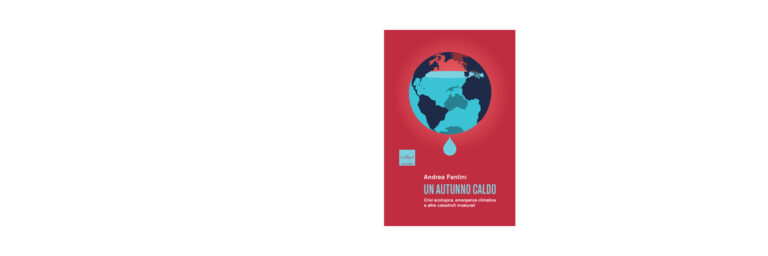
Il titolo di questo libro è piuttosto curioso e da interpretare. Forse si allude da un canto ai recenti e prossimi autunni caldi più del consueto per via della crisi climatica e dall’altro all’aspettativa o all’auspicio di una prossima stagione di lotte dalla portata paragonabile allo storico “autunno caldo” del ’69 operaio.
L’autore ha studiato scienze geografiche, ambientali e agroforestali alle università di Bologna e Barcellona, dove ha conseguito un dottorato, e si è specializzato in agroecologia, economia ecologica e politiche agroambientali. In questo testo condensa anni di ricerca cercando di delineare l’attuale crisi ecologica, indicando in conclusione che cosa sia auspicabile mettere in campo per fronteggiarla e su quali forze sia possibile contare.
Dunque il corpo del volume è l’analisi dell’attuale crisi, con due pregi da segnalare: un’attenzione apprezzabile alla profondità storica dei processi che l’hanno determinata e la preoccupazione di non ridurre il tutto, come è oggi di moda, alla crisi climatica ed energetica. Ovviamente il punto di vista è condizionato dalla formazione geografica ed agroforestale, per cui prevalgono i temi legati a questi ambiti disciplinari. E giustamente parte dalle riflessioni precorritrici di Humboldt (1769-1859) per introdurre l’attuale dibattito controverso su Antropocene o Capitalocene: “Uno dei primi autori ad analizzare con metodo scientifico l’impatto delle attività umane e gli effetti dell’uso eccessivo e scriteriato delle risorse naturali è Alexander von Humboldt, il celebre naturalista e geografo giramondo, considerato oggi, a buon diritto, il precursore della scienza ecologica” (p. 19). Quindi tratteggia la propensione della modernità all’accaparramento delle risorse naturali, dai primi viaggi di esplorazione, al colonialismo e neocolonialismo, all’attuale economia estrattivista e di rapina del neoliberismo. Nel successivo capitolo si sofferma sul processo storico della costruzione tecnologica e di potere della megamacchina che sorregge l’attuale economia termo-industriale basata sui fossili. Ma non si limita, giustamente, a evidenziare i limiti della Tecnica: è il sistema capitalistico intrinsecamente e strutturalmente incapace (le trappola illusionistiche del PIL e della crescita infinita…) a misurasi realmente con le leggi dell’ecologia; un sistema, inoltre, ferocemente classista, dove la condizione di chi sta in basso è spesso ai limiti della sopravvivenza rispetto a chi sta in alto immerso nel lusso e nello spreco, insomma, la metafora classica della navicelle spaziale di Boulding rivista con quella dell’“astronave a più piani”.
Quindi la seconda parte del volume, L’incendio alle porte di casa, è dedicata ad una puntuale disamina della crisi climatica, degli effetti sulla biosfera terrestre e marina, dell’irriducibilità dei disastrosi processi di urbanizzazione e dell’enorme fabbisogno di materia ed energia per alimentarli, con i conseguenti conflitti e migrazioni di popoli. Un’analisi complessivamente esaustiva, che rappresenta un indubbio pregio di questo impegnativo lavoro.
La terza parte tenta di tracciare alcune proposte e linee di azione per come “uscire dal tunnel” individuando anche alcuni soggetti che in quella direzione si starebbero muovendo.
Partendo dalla lodevole constatazione che si tratta di un’impresa titanica, l’autore ritiene che “il modo migliore al momento, considerata la forza ideologica del modello dominante, è operare negli interstizi e nelle crepe di un edificio che solo in apparenza appare solido e durevole. È qui che albergano quelle contraddizioni, come direbbe il poeta, che aprono speranze” (p. 188).
Seguono poi alcuni possibili e auspicabili (nonché condivisibili) obiettivi: innanzitutto “la riduzione delle ore lavorative” come asse di una necessaria ripresa “del conflitto capitale-lavoro e della lotta di classe”. Quindi “bagatelle” come il controllo politico dei flussi di capitale, assicurare politiche di ridistribuzione fondate su criteri di progressività e servizi di base per tutti (abitazione, educazione, cibo, salute ecc.), tassare i grandi capitali e le rendite finanziarie e immobiliari garantendo con il gettito che ne deriva un reddito universale di esistenza, limitare oltre una certa soglia la proprietà privata e privilegiare piuttosto modelli di proprietà temporanea, subordinata all’uso (preminenza del valore d’uso sul valore di scambio), studiare strumenti di politica economica che evitino l’accumulazione e la ricchezza come forme di potere sociale, sottrarre al grande capitale privato e ricollettivizzare le risorse chiave (acqua, energia, serbatoi di biodiversità ecc.), pianificare le scelte produttive a seconda della disponibilità ecologica (pp. 199-200).
Pur riconoscendo che vi è “una questione di scala” con cui si dovrebbe fare i conti, e che quindi sarebbe necessaria “una riorganizzazione popolare a livello internazionale” (p. 205) sembra che questo enorme problema possa ridursi ai soliti esempi virtuosi di Via Campesina o del movimento Sem Terra, francamente poca cosa a maggior ragione se si dà per scontato che l’attuale processo di globalizzazione continui a svilupparsi. In questa parte, forse, sarebbe auspicabile un aggiornamento delle tendenze in atto: da un canto la globalizzazione da diversi anni tende a ridursi, sia per la mole delle merci movimentate, sia per le arre degli stessi scambi, in ragione del trauma del Covid, ma anche della constatazione che l’unun imperium sognato dagli Usa dopo il crollo dell’Urss non si è realizzato e, dall’altro, si sta imponendo un mondo multipolare, con una geopolitica molto articolata, in cui gli Stati o aggregazioni di Stati, anche periferici, possono tornare a svolgere un ruolo importante.
E qui veniamo ad un’altra “questione cruciale: quella dello Stato” (p. 208). E’ giusto “riconoscere e rompere l’alleanza tra capitale e Stato” (p. 210), ma ciò non basta. Vi è un fattore nuovo, che potrebbe cambiare l’attuale quadro piuttosto sconfortante. Un fatto che appare come un clamoroso elemento di contraddizione: il neoliberismo è sempre più sfacciatamente “impuro”, se, per salvarsi dal baratro della crisi, dopo aver predicato per decenni “meno Stato e più mercato” oggi invoca il “ritorno dello Stato” (P. Gerbaudo, Controllare e proteggere. Il ritorno dello Stato, Nottetempo, Milano 2022) e addirittura il “Piano”, considerato fino a ieri, con orrore, un groviglio di “lacci e laccioli” che mortifica le radiose prospettive della crescita capitalista. Si tratta di centinaia di miliardi di finanziamenti pubblici che sono in gioco, con il Pnrr e non solo (nel caso degli Usa migliaia di miliardi di dollari!). Ma questo “neostatalismo”, praticato e non dichiarato, non prelude necessariamente ad una svolta qualitativa. In sostanza sono possibili diversi neostatalismi: quello che si preoccupa di salvaguardare i privilegi dei potenti e che per conseguire nonostante tutto profitti nell’attuale sistema tenta di aggirare ancora i limiti naturali della crescita con ulteriore distruzione di risorse, oppure quello che si cura di garantire a tutti lavoro, diritti e dignità e che assume le leggi dell’ecologia come guida per riconvertire l’economia umana.
È fin troppo evidente che un neostatalismo eco-sociale per imporsi deve reggersi non solo su forme di controllo e di partecipazione democratiche, ma sulla ricostruzione di un grande movimento di massa, autonomo e capace di iniziativa e cultura alternative, radicato nella società, nei cosiddetti corpi intermedi, sindacati, associazioni ambientaliste, organizzati su base democratica e popolare, con una potente forza d’urto ed all’occorrenza di conflitto. Ma occorre anche aggiungere che l’alternativa ha bisogno di progettualità (Giorgio Nebbia fino alla fine della sua vita non si è mai stancato di delineare piani e progetti a medio e lungo termine) e di strumentazioni per elaborare ed attuare quella che noi chiamiamo conversone ecologica e sociale (lo Stato “snello” oggi si ritrova senza uffici studi di alto livello, senza strategie economiche e industriali alternative alle semplici tendenze del mercato, con aziende formalmente a capitale pubblico dirette dagli indici di borsa, insomma del tutto impotente ad affrontare la crisi). Si tratta, a mio parere, di una sottovalutazione, presente anche nel pregevole lavoro di Fantini, che ha radici lontane, nella sconfitta storica del movimento operaio novecentesco, nell’ondata neoliberista apparsa come invincibile, per cui non rimaneva che “operare negli interstizi”, diffondendo pratiche virtuose dal basso, nelle comunità, la cosiddetta strategia “lillipuziana”, illusione dura a morire, nonostante più di un quarantennio ne abbia certificato la sostanziale inconsistenza. Rimane insomma il problema: con quale strumentazione politica possiamo porre mano a quegli obiettivi ambiziosi che anche il nostro indica riassumendoli in formule suggestive con efficaci titoletti dei rispettivi paragrafi, Rilocalizzare, Convertire e riprogettare, Ripensare la produzione di spazio e movimento in senso ecologico, Riecologizzare la produzione agroalimentare, Riunire saperi, condividere conoscenze.
La conclusione, infine, richiama i valori fondativi di un modo diverso dell’umanità di stare sul Pianeta, riassunto in “una questione di cura e relazione” che dovrebbe alimentare “l’azione collettiva, imprescindibile per dare forza alle battaglie”. Certamente cura e relazione sono imprescindibili per costruire un rapporto positivo tra gli umani e tra questi e la natura. Mi permetto di aggiungere un’altra parola chiave che ci hanno insegnato i nostri maestri: prevenzione, delle malattie e degli infortuni, dell’inquinamento, della povertà, dell’eccesso consumistico, dei conflitti…
Ma sarebbe sbagliato pretendere un’assoluta compiutezza da un lavoro così impegnativo e su una tematica tanto complessa e controversa. Non credo fosse neppure l’intenzione dell’autore che ci consegna comunque un prodotto di eccezionale interesse.