I beni comuni: un’alternativa al capitalismo
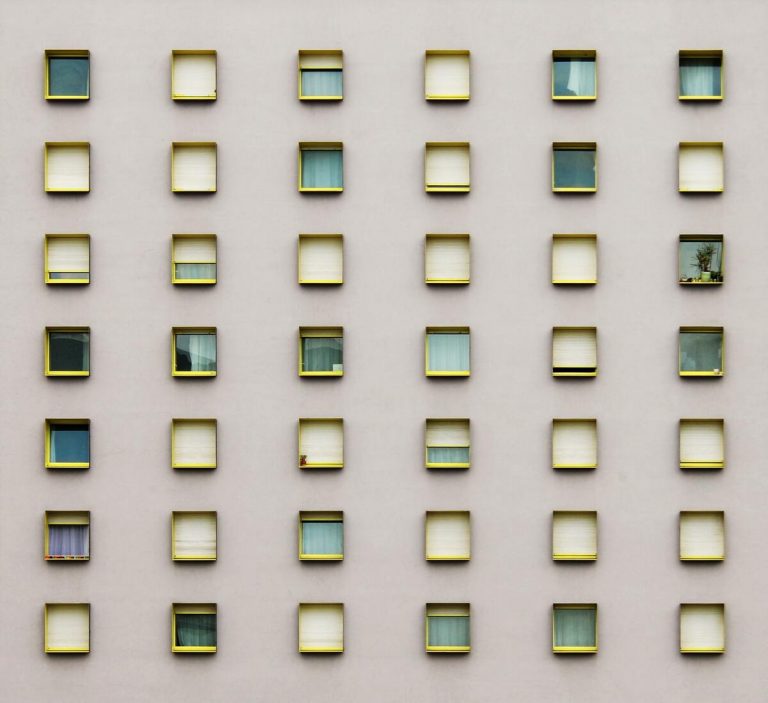
La tesi sostenuta nel mio recente libro, Beni comuni vs Merci, Milano, Jaca Book 2010 (che presto uscirà anche in inglese) è che i beni comuni del passato – quelli di sussistenza – possono esprimere, se riletti e aggiornati alla luce del presente, un modello istituzionale, sociale e politico alternativo a quello capitalistico, che domina sul mondo da circa tre secoli. Hanno questa valenza perché minano il capitalismo da tre angolature essenziali al capitalismo: l’economia di mercato, la proprietà privata e la democrazia. I beni comuni usano le risorse naturali in modo da non esaurirle e privilegiano la cooperazione al posto della competitività, riformulando così la nozione di produttività in termini di sostenibilità sociale ed ecologica e di partecipazione al sentire degli altri (i sentimenti morali di Adam Smith); sono utilizzati in comune senza essere di proprietà né pubblica né privata, e questo ridimensiona la nozione di proprietà, privata e pubblica; sono autogestiti dalle comunità e popolazioni locali, ed esprimo pertanto una forma di democrazia diretta che integra e rilegittima quella rappresentativa, divenuta insufficiente nel capitalismo globale. In breve, i beni comuni o commons sono beni e servizi che non si trasformano in merci da scambiare sul mercato capitalistico.
Mi rendo conto che questa proposta può sembrare punitiva nei confronti dei cosiddetti paesi in ritardo di sviluppo, fortemente impegnati a raggiungere gli standard di vita occidentali. A questa possibile domanda, rispondo in due modi: primo, la proposta riguarda soprattutto i paesi del Nord che vivono al di sopra delle proprie risorse naturali, a spese del resto del mondo. Secondo, la proposta è paradigmatica – e in questo senso può interessare anche il Sud – e tende a sottolineare che occorre promuovere e praticare modi di produzione e sistemi di vita più rispettosi della natura, capaci di valorizzare la cooperazione e la solidarietà tra gli uomini.
Questa proposta non è più solo l’auspicio di un numero crescente di studiosi e di attivisti ma una necessità storica, che si pone sempre più spesso di fronte alla crisi del sistema dominante, per arginare il saccheggio della natura e l’imbarbarimento sociale; nel Sud del mondo, la fame e la morte per fame per oltre un miliardo di persone. Il cambiamento climatico, la privatizzazione delle risorse naturali e dello spazio pubblico, le nuove povertà, la disoccupazione specie dei giovani e delle donne, l’esclusione e la marginalità sociale, l’insicurezza alimentare, le nuove malattie causate dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e delle catene trofiche sono solo alcuni dei tratti salienti del capitalismo ne finanziario, che produce ricchezza “di carta” mentre distrugge ricchezza reale.
A sostegno della priorità da me assegnata ai beni comuni di sussistenza, avanzo due considerazioni: primo, la constatazione che agli inizi del terzo millennio le frontiere del profitto si sono spostate sui beni comuni e sui beni pubblici, e cioè sul patrimonio consolidato di beni naturali, infrastrutturali e di servizi, il cui valore è in parte un “regalo” della natura e in parte frutto dell’ingegno e del lavoro delle comunità e delle popolazioni locali. Una ricchezza collettiva molto appetibile per le grandi multinazionali e per la finanza, di cui le popolazioni locali devono riappropriarsi; una ricchezza che è al centro dello scontro sociale e delle infinite guerre ad alta e bassa intensità in corso in molte parti del mondo.
Secondo, la convinzione che i beni comuni naturali legati ai quattro elementi vitali identificati da Empedocle, il filosofo greco-siciliota già nel quarto secolo a.C., sono prioritari dal punto di vista della costruzione dell’alternativa, perché da essi dipende la sopravvivenza di tutti, poveri e ricchi: l’aria, l’acqua, il suolo e l’energia non si possono produrre in laboratorio. Storicamente, i beni comuni sono stati quelli essenziali alla sussistenza – cibo, acqua, una “casa” – ma è evidente che la sussistenza è un concetto relativo, socialmente e storicamente determinato, che varia nello spazio e nel tempo. Nella cultura occidentale, ormai largamente diffusa anche al Sud, è dato per scontato che i beni essenziali alla sussistenza siano forniti dal mercato, trascurando il fatto che il mercato non sa “produrre” né l’aria né l’acqua. Non sa fare scelte efficienti di allocazione delle risorse naturali, e tutti i tentativi di correggere questo limite del mercato non hanno evitato né il degrado e lo spreco delle risorse né l’ingiustizia sociale. L’acqua ad esempio non era scarsa prima, quando era gestita dalle comunità locali e indigene con tecniche di captazione, conservazione e utilizzo tradizionali, con una sapienza collettiva frutto dell’impegno, dell’ingegno e del lavoro di tutti i componenti della comunità.
La convinzione, molto diffusa nella cultura occidentale, che i beni comuni materiali o di sussistenza riguardino solo i paesi del Sud in ritardo di sviluppo, e che gli altri beni comuni – culturali, sociali e digitali – riguardino invece soprattutto il Nord, è pertanto profondamente errata: è falsa sul piano fattuale perché la gestione comune delle risorse naturali è spesso più efficace ed efficiente di quella pubblica o privata sia nei paesi del Sud che in quelli del Nord, come ha dimostrato Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia nel 2009 (Governare i beni comuni, Marsilio, Venezia 2009). Ed è controproducente sul piano politico perché traccia una linea orizzontale di divisione tra Nord e Sud, favorendo l’esclusione e il razzismo – è un altro modo con cui l’Occidente difende i suoi privilegi e giustifica il saccheggio del Nord sul Sud.
Identikit dei beni comuni
I beni comuni sono stati la forma di organizzazione sociale prevalente nel Medioevo europeo e sono ancora oggi una realtà importante nei paesi del Sud del mondo dove le comunità di villaggio, spesso indigene, sono una presenza significativa: nella maggior parte dei paesi dell’Africa sub-sahariana, in tutti i paesi dell’Asia sud-orientale incluso l’India e la Cina, nei paesi andini dell’America latina. Fonti delle Nazioni unite stimano che oltre due terzi della popolazione mondiale, nelle campagne e nelle vicine foreste, vive ancora oggi grazie all’accesso diretto alle risorse naturali di sussistenza.
Storicamente, dunque, i beni comuni naturali sono risorse collettive condivise, amministrate e auto-gestite dalle comunità locali. Non sempre si tratta di risorse in senso proprio, e cioè di beni fisici o materiali come un campo da coltivare, un pascolo, un corso d’acqua, una zona di pesca; possono essere anche diritti d’uso sui frutti derivanti da un bene naturale – i common rights della common law anglosassone, gli usi civici nella tradizione giuridica italiana; le “servitù” che ancora oggi gravano sui beni naturali, grazie ai quali le comunità ricavano o integrano i loro mezzi di sussistenza; il patrimonio delle risorse genetiche naturali, oggetto del Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Agricoltura e l’Alimentazione del 2001 (Lorenza Paoloni, Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità, Torino, Giappichelli, 2005).
Non esiste una definizione unica e univoca dei beni comuni naturali, la cui forza e ragion d’essere è proprio la loro diversità, la specificità di luogo e la flessibilità con cui le comunità – i soggetti titolari dei beni comuni – sono riusciti ad adattarsi al variare delle situazioni. E’ possibile tuttavia descriverne i tratti distintivi, il primo dei quali è proprio la loro adattabilità e flessibilità. Un altro è l’auto-organizzazione della comunità, che può indicare sia il gruppo di persone che gestiscono insieme il bene naturale o ne godono i diritti d’uso; oppure l’autorità di villaggio che distribuisce le terre fertili tra le famiglie del villaggio, affinché le coltivino per il consumo della famiglia, non a fini mercantili.
La comunità opera secondo una logica diametralmente opposta a quella del mercato capitalistico, nel senso che nella comunità non vale la dimensione astratta delle relazioni mercantili mediate dalle merci, ma la dimensione concreta delle relazioni interpersonali che rispondono al bisogno di socialità insito negli esseri umani. Ma proprio per questo la comunità è un concetto controverso, che non gode di buona reputazione nella cultura dominante del Nord.
I beni comuni sono anche ecosistemi biologici e culturali, e in quanto tali sono alla base della vita perché assicurano beni essenziali quali l’acqua e l’aria, il cibo, la casa, i combustibili e i medicinali. Beni che il moderno mercato capitalistico può fornire solo in parte, e comunque sotto forma di merci da acquistare sul mercato a condizioni di prezzo e di fornitura che i consumatori sono costretti a subire, senza nessun controllo sulla allocazione delle risorse naturali nè sui prezzi e sulla qualità dei prodotti messi sul mercato.
La distinzione tra beni comuni locali e beni comuni globali, spesso riportata in letteratura, è poco fondata perché “il globale è sempre un locale globalizzato” (Vandana Shiva, “The Greening of the Global Reach”, in W. Sachs, a cura di, Global Ecology, Zed Books, Londra 1993). Il sistema globale che oggi governa il mondo non è infatti universale in senso epistemologico, ma la versione globalizzata di una tradizione locale – quella del capitalismo mercantile di matrice europea – che si è imposta al mondo con la forza e con la violenza dello sfruttamento e del colonialismo.
I beni comuni naturali sono dunque sistemi locali, diversi nello spazio anche nello stesso periodo storico, e proprio per questo rappresentano una alternativa reale (ma non la sola alternativa) al paradigma del mercato: la loro diversità e flessibilità permette di utilizzare al meglio le risorse naturali su cui i beni comuni insistono, evitandone il sovrasfruttamento, il degrado e la distruzione che è invece una conseguenza ineliminabile del modello capitalistico. Permettono inoltre di attivare le risorse umane di creatività, intelligenza ed energia delle persone, che sono le più scarse e le più importanti in assoluto per una società ecologicamente e socialmente sostenibile.
La delegittimazione dei beni comuni
La sottovalutazione dei beni comuni materiali, e per converso la sopravalutazione dei beni comuni immateriali, è frutto del processo storico europeo di “derubricazione” della natura, che è al centro della occidentalizzazione del mondo.
Nel passaggio dal Medioevo alla Modernità, i beni comuni diventarono un ostacolo al cambiamento e al “progresso”, e furono messi da parte. In Inghilterra le terre comuni vennero recintate e privatizzate (l’accumulazione originaria), per produrre la lana necessaria alla nascente manifattura tessile e liberare la forza lavoro da impiegare nelle fabbriche. Per realizzare la Rivoluzione industriale, l’Inghilterra conquistò buona parte delle Americhe (“seconda” accumulazione originaria) e deportò milioni di africani da impiegare come lavoro schiavile nelle piantagioni di zucchero delle colonie. (Giorgio Pietrostefani, La tratta atlantica. Genocidio e sortilegio, Milano, Jaca Book, 2000). Conquistò inoltre una parte dell’Asia, da usare come “vacca da mungere” per gli investimenti necessari nelle nuove tecnologie di produzione industriale (Marcello De Cecco, Moneta e impero. Il sistema finanziario internazionale dal 1850 al 1914, Torino, Einaudi, 1979).
Le conseguenze sociali di questi eventi sono state analizzate e denunciate da studiosi come Karl Marx (Il Capitale, Roma, Editori Riuniti 1968) e Karl Polanyi (La grande Trasformazione, Torino, Einaudi, 1974). Le conseguenze ambientali si sono sviluppate nel tempo, e sono tuttora in corso come nel caso del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità (Alfred Crosby, Imperialismo ecologico. L’espansione biologica dell’Europa 900-1900, Bari, Laterza, 1986).
L’emergere della economia politica come “scienza”, alla fine del 17 secolo, contributi significativamente al tramonto dell’ordine sociale esistente prima della Rivoluzione industriale. I padri fondatori dell’economia politica– da Adam Smith a David Ricardo a John Stuart Mill – si sono tutti schierati dalla parte della società di mercato, aspramente criticata da molti autori e soprattutto da Karl Marx e da Karl Polanyi, della superiorità del mercato capitalistico, dell’homo oeconomicus e della “mano invisibile”. Queste teorie giustificarono l’espansione del mercato capitalistico e contribuirono a creare una nuova ideologia, che cancellò anche la memoria dei beni comuni – prima tra gli intellettuali e le classi al potere; dopo – lentamente ma inesorabilmente – anche tra le masse
La sottovalutazione della natura ha avuto effetti devastanti e duraturi nel tempo, che si sono estesi al mondo intero: ha “legittimato” la schiavitù e il colonialismo che arriva fino ai giorni nostri; lo sfruttamento delle risorse altrui da parte di comunità e di popoli che vivono al di sopra delle loro risorse; ha permesso l’introduzione su vasta scala della chimica in agricoltura, provocando l’eutrofizzazione dei laghi, dei fiumi e anche del mare in alcuni casi, e minando la sicurezza alimentare; l’uso generalizzato di energia fossile e il conseguente surriscaldamento climatico, l’impiego di tecnologie, macchinari e sostanze tossiche e cancerogene nelle fabbriche, nei cantieri, nelle miniere e in agricoltura, luoghi dove i lavoratori vanno a morire come fossero in guerra.
Il “ritorno” dei beni comuni: una proposta
La crisi del capitalismo globale, esplosa nel 2007 con il default dei mutui subprime statunitensi, ha messo in crisi anche la politica e i partiti politici come strumento di gestione della politica. Da più parti si chiede che i partiti politici si facciano da parte e che il loro posto sia preso dai movimenti.
Nei paesi ad elevato sviluppo industriale e tecnologico i movimenti sono – e sempre di più devono diventare – i soggetti dell’alternativa; la versione contemporanea delle comunità di autogestione dei beni comuni del passato. Pensando all’Italia di oggi, si può affermare che fanno parte dei movimenti per l’alternativa gli operai delle fabbriche in crisi; i giovani disoccupati; i comitati di cittadini in lotta contro gli scempi ambientali e urbanistici; le organizzazioni di chi sta provando ad imboccare strade alternative. E poi brandelli di amministrazioni locali, di organizzazioni sindacali, di associazioni professionali e culturali, di piccoli e medi imprenditori cancellati dalla crisi economica; di nuove leve disposte a confrontarsi con il mercato in una prospettiva sociale non di rapina. Questi soggetti esistono già in forme diverse in tutti i paesi del mondo al Nord e al Sud, e cercano di aprire un nuovo e rinnovato spazio pubblico, diverso da quello statuale.
Il contesto culturale in cui questi soggetti/movimenti possono lavorare per l’alternativa è definito dai limiti della natura, e richiede la conversione ecologica delle produzioni e la riterritorializzazione dei mercati, a partire dai settori più sensibili che in Italia (e non solo) sono quello dell’automobile oggi obsoleto, da ridefinire nella mobilità sostenibile e con l’uso delle energie rinnovabili; le energie rinnovabili appunto, non inquinanti e decentrate sul territorio anziché geograficamente concentrate in una decina di paesi e controllate da una decina di multinazionali come sono le energie fossili; l’agricoltura organica e contadina; la cura e la manutenzione del territorio, oggi ridotto a merce edificatoria; l’uso e il riuso dei metalli e dei minerali perché scarsi in natura o resi scarsi dal sovra-sfruttamento, la difesa del suolo, il servizio idrico integrato, i sevizi pubblici locali ed altri ancora.
Nonostante i danni prodotti dal sistema capitalistico superino ormai di gran lunga i vantaggi individuali che il sistema assicurava prima ad una parte soltanto della popolazione mondiale, la critica al sistema stenta a trasformarsi in alternativa di sistema, sia per la strenua resistenza delle forze e delle classi dominanti, che da questa situazione traggono vantaggio e che hanno a disposizione gli strumenti per imporre la loro prevaricazione, sia perché non esistono leadership dotate di una visione strategica realmente alternativa a quella del mercato, capaci di mobilitare le masse. Ma la situazione potrebbe anche cambiare se la risposta dei movimenti sociali fosse più forte e più decisa, visto che i beni comuni naturali riguardano innanzitutto i beni primari che rispondono ai bisogni essenziali di fasce sempre più consistenti di popolazione impoverita e disoccupata, a causa delle ferree “leggi” imposte dal mercato capitalistico.
Il ritorno dei beni comuni si colloca in questa prospettiva strategica. Richiede di considerare i movimenti ambientali e sociali e i comitati di lotta che operano in difesa delle risorse naturali e della sostenibilità ambientale come istanze che esprimono le esigenze del territorio. Per svolgere questo ruolo, i movimenti debbono ottenere riconoscimento giuridico ed essere dotati della sovranità di decidere sulle risorse locali e sulle questioni locali non da soli ma insieme altre istanze che hanno già titolo a farlo come i governi locali e le associazioni di categoria.
La proposta qui avanzata dovrebbe infine essere “problematizzata”, per compensare le differenze naturali, storiche e geopolitiche dei territori tenendo conto che le comunità – come la natura umana – non sono sempre “buone e giuste”. Il ritorno dei beni comuni non potrà diventare un’alternativa al capitalismo se le nuove comunità non saranno solidali al loro interno e aperte al mondo esterno: cosmopolite.