La tecnopolitica salverà il mondo?
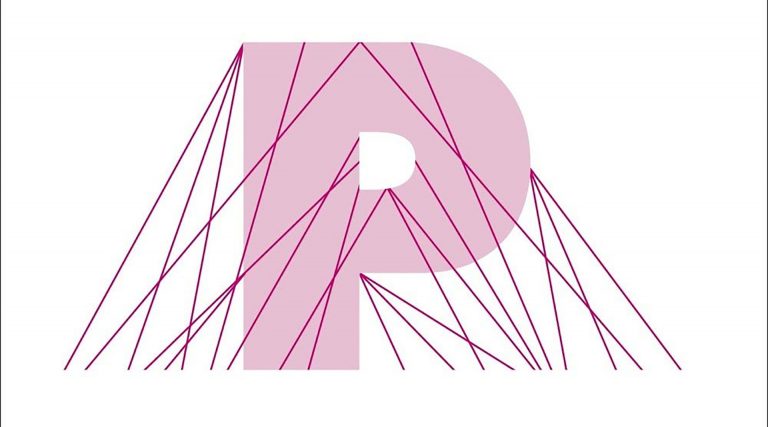
P. Vineis, L. Carra, R. Cingolani, Prevenire. Manifesto per una tecno politica, Einaudi, Torino 2020.
La lettura di un testo non è mai stata per me così intrigante come Prevenire. Manifesto per una tecnopolitica. Per svariate ragioni. Innanzitutto il titolo ed il sottotitolo. Prevenire per chi ha una cultura ambientalista e democratica è un concetto quasi sacro, fondamentale per preservare la buona salute sia della natura che degli umani. Tecnopolitica, invece, presenta immediatamente elle ambiguità, perché da un canto evoca l’idea oligarchica del governo dei sapienti in alternativa alla democrazia implicitamente considerata governo dei mediocri, e dall’altro sembra proporre ancora una volta la tecnologia come chiave di volta per la soluzione dei problemi dell’umanità. Insomma, titolo e sottotitolo evocano risonanze di ossimoro. Gli interrogativi aumentano se poi si tien conto che il libro è uscito l’anno scorso e che uno egli autori, Roberto Cingolani, è ora direttamente coinvolto in un ruolo preminente come tecnico nell’attuale inedito governo Draghi, il cui collante dovrebbe essere proprio una politica al di sopra e al di là delle ideologie e degli schieramenti partitici, in nome delle cose tecnicamente fondate da farsi per la salvezza del Paese. In questo senso un saggio apparentemente profetico che avrebbe anticipato (preparato?) di qualche mese gli eventi. Ma lo stupore non finisce qui. La firma di Roberto Cingolani, personaggio ormai troppo noto, è preceduta da due altre firme importanti. La prima, che sembrerebbe abbia offerto il contributo più robusto al testo, è quella di Paolo Vineis, illustre epidemiologo proveniente dalla scuola di “Epidemiologia & prevenzione” e alla lontana di Giulio A. Maccacaro, ora vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, docente di Environmental Epidemiology presso l’imperial College di Londra e Visiting Professor all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, lo stesso diretto da Cingolani fino al 2019. La seconda di Luca Carra, divulgatore scientifico, già membro di Italia nostra e direttore di “Epidemiologia & prevenzione”, segretario del “Gruppo 2003 per la ricerca”, associazione di scienziati italiani, nonché direttore della rivista on line, “Scienza in rete” e promotore del manifesto “Scienza in Parlamento”, in cui si chiede l’istituzionalizzazione di un Comitato tecnico-scientifico che in permanenza affianchi e assista gli organi decisionali democraticamente eletti.
Viste le premesse la lettura del testo non solo è impegnativa, ma anche non facilmente riducibile ad una valutazione univoca.
Da un canto vi è l’assunto, in linea generale condivisibile, che l’umanità si trovi di fronte a tre enormi debiti: il debito socio-economico, il debito ambientale ed il debito cognitivo. E che per affrontarli sia necessario un “radicale cambiamento” (p. 3).
Dopodiché si afferma che, grazie alla tecnologia, “non possiamo negare che il mondo nel suo complesso sia migliorato, in contrasto con la percezione diffusa” (p. 5) e ancora che “il mondo di oggi è il migliore che abbiamo avuto dall’inizio della storia umana” (p. 70). In questa oscillazione, tra analisi critica a volte senza sconti del presente e fiducia in un progresso lineare e permanente garantito dall’innovazione tecnologica si muove l’argomentare del saggio.
Insomma i problemi ci sono, ma la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica sono in grado di risolverli, purché si sappia ricomporre il rapporto tra scienza, tecnologia e politica.
Ovviamente un filo conduttore è la polemica contro lo scetticismo antiscientifico, emblematicamente rappresentato dai No-vax, dai movimenti localistici e neonazionalistici, nonché dai populismi, che non hanno compreso come il “prevenire” per essere efficace debba porsi necessariamente a livello internazionale. Perché, e qui siamo all’ovvio, “non esistono soluzioni semplici a problemi complessi”. “Un altro pregiudizio diffuso (comune a diversi movimenti populisti, pur nella loro eterogeneità) consiste nel proporre e far circolare l’idea secondo cui (una volta liberatici della casta degli esperti) ci sarebbero soluzioni semplici per problemi complessi. Non è cosi. Tipica dei social media non è soltanto la diffusione di fake news, ma l’idea che «da qualche parte» esisterebbe una soluzione, se di mezzo non ci fossero la casta e i poteri forti” (p. 100). Non si può non notare qui un lapsus piuttosto imbarazzante degli autori, laddove di fatto si ipotizza di identificare la “casta degli esperti” con “la casta e i poteri forti”. Il tema della critica della scienza, della sua presunta neutralità rispetto al potere ed agli interessi in campo è troppo importante per essere liquidato in questi termini caricaturali. Vi è una vasta letteratura, in particolare a partire dagli anni Sessanta, sul tema, nel quale tra tanti altri, si sono impegnati proprio Maccacaro e Lorenzo Tomatis, già direttore dell’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro dell’Oms, peraltro citato in questo volume (p. 104). È pur vero che qui e là si accenna di sfuggita ai conflitti di interesse ed anche ad una qualche critica alle logiche di mercato, ad esempio rispetto ad un buon sistema sanitario, ma sul punto alla fine si rivendica un’autonomia della ricerca scientifica che, ancor più nel sistema neoliberista oggi trionfante, fa molta fatica ad apparire credibile. “È dunque legittimo pensare che lo scienziato o il tecnologo abbiano una loro linea di ricerca autonoma, ponendosi liberamente obiettivi e questioni da risolvere ma al contempo vengano interpellati dal potere politico e dalla società e «deviino» dunque il corso delle loro ricerche per soddisfarne le richieste” (pp. 85-86). Una visione francamente ottimistica, che non sembra corrispondere ad una realtà come l’attuale, di politica debole se non evanescente e di società disgregata, almeno nei suoi corpi intermedi, in cui le leve del comando, anche della ricerca, sono in mano soprattutto ai gruppi multinazionali economici e finanziari e, nelle grandi potenze, ad un complesso tecnologico-militare sostanzialmente autoreferenziale. Ignorare questa realtà fa sì che si legittimi proprio quella sfiducia nella scienza che si vorrebbe contrastare. E questa riflessione vale anche per la polemica nei confronti delle chiusure nazionali, che sarebbero anch’esse antiscientifiche perché la scienza dimostra che a questo livello i problemi non si possono risolvere. Per cui il saggio conclude con una raccomandazione che chiunque sottoscriverebbe: “È necessaria infine una dimensione internazionale della salute, dell’ambiente e dell’economia, che prevalga sulle chiusure localiste e improntate alla paura dell’altro. Un nuovo, e pacifico, internazionalismo” (p. 118). Sennonché alle viste l’unico internazionalismo reale e ben consolidato, che in genere troppi, compresi gli autori, non si sognano di mettere in discussione, è appunto quello della grande finanza e delle multinazionali, dove le sfibrate e acciaccate istituzioni internazionali non riescono ad imporre a Big Pharma la sospensione dei brevetti neppure davanti alla sconvolgente ecatombe del Covid 19.
Ma l’argomentazione nel testo su questo tema cruciale è particolarmente sofisticata e ambivalente: da un canto si ridicolizza chi osa immaginare un rovesciamento dell’ordine costituito bollandolo come fanatico sostenitore dei metodi Di Bella e Vannoni, dall’altro si riconoscono, ad esempio, i limiti delle cure praticate oggi dalla scienza ufficiale per la cura dei tumori. “Questo [che a problemi complessi vi sia una “soluzione a portata di mano”. Nda] è un pregiudizio da sfatare, perché alimenta la falsa aspettativa che un rovesciamento dell’ordine costituito consentirà non solo di «liberare» la ricerca vera dalle catene della corruzione, ma anche di risolvere problemi incombenti (si pensi ai vari casi Di Bella e Vannoni). Al contrario, non sappiamo se riusciremo a trovare una cura efficace per tutti i tumori, [.…].Negli stessi Paesi ricchi la spinta a sviluppare nuovi farmaci, nuove tecniche chirurgiche e radioterapiche è diventata economicamente quasi insostenibile. Come già detto, delle 277 terapie farmacologiche per il cancro di cui nel periodo 2011-15 sono state pubblicate sperimentazioni cliniche, soltanto il 15 per cento ha portato miglioramenti significativi nella sopravvivenza o nella qualità della vita. Diversi studi rivelano che in molti casi più i farmaci sono costosi, meno sono efficaci, e tuttavia sono largamente in uso…” (pp. 101-102). Un’argomentazione, quest’ultima, del tutto condivisibile che serve agli autori per avvalorare la tesi che la lotta contro i tumori è più efficace e meno costosa se si puntasse sulla prevenzione. Ma sarebbe stato utile che venisse spiegato anche perché la ricerca scientifica spinge invece in tutt’altra direzione.
Molto spazio viene dato, comunque, all’analisi ben documentata delle cause profonde dei tre debiti di cui si è detto. Del tutto condivisibili le considerazioni che vengono sviluppate sul debito socio economico, con largo impiego degli studi di Piketty, e su quello ambientale con approfondimenti da sottoscrivere, ad esempio, sull’impronta ecologica, sulla sesta estinzione, sul rapporto con la salute umana. Forse più discutibile l’enfasi sull’infosfera a proposito del debito cognitivo. Pur riconoscendo lo stress sistemico che può indurre il senso di inadeguatezza personale alla mole di informazioni incommensurabile potenzialmente circolante sulla rete, si conclude con un’ipotesi di “ecologia della mente” che allo scrivente appare ancora lontana da perseguire in dimensioni realmente democratiche e alla portata di tutti: “L’ecologia della mente dovrà promuovere il bene pubblico dell’infosfera, aumentando il grado di «infodiversità» proprio come si fa – o si dovrebbe fare – con gli ecosistemi. Sulle piattaforme del mondo digitale si può già oggi intervenire con strutture diverse, di natura collaborativa, come nel caso di Wikipedia, o del media sociale «per introversi» Pinboard, o la piattaforma formativa Coursera. Stanno nascendo in questi anni – come ricorda Luca De Biase – gruppi animati da un’etica del «codice d’onore», che lavorano alla «continua riprogettazione delle forme della rete, per l’impegno contro l’inquinamento disinformativo e per la creazione di spazi di aria mentale pura». Anche il tramonto dell’opinione pubblica descritto da Cass Sunstein e Jurgen Habermas potrebbe venire contrastato dalla nascita di nuovi media civici, che, molto meglio dei social egocentrici attuali, potranno agevolare forme di dialogo pluralistico per deliberare in merito al bene comune.
Infine, sempre l’ecologia della mente sembra ispirare un nuovo modo di progettare dispositivi e impieghi dell’intelligenza artificiale basati sul concetto di embodiment, vale a dire una visione del cervello non disgiunta dal corpo, in particolare delle sue componenti senso-motorie, fondamentali per i processi cognitivi. Da qui, per esempio, i progetti in via di definizione della cosiddetta robotica sociale, per impiegare i robot nella comprensione e cura dell’autismo e di altri disturbi cognitivi e comportamentali. La grande promessa della robotica e dell’intelligenza artificiale è proprio quella di trasformare la tecnologia da potenziale acceleratore patologico a supporto essenziale per la cura delle malattie dell’anima” (p. 83).
Molto interessanti le pagine dedicate alla prevenzione in particolare delle malattie dello sviluppo, cosiddette cronico degenerative (obesità, diabete, patologie cardiocircolatorie, tumori…), all’importanza dei fattori ambientali in senso lato (alimentazione, stili di vita, inquinamento…), all’epigenetica (pp. 58-63).
Anche se, a parere dello scrivente, si enfatizza il ruolo dell’alimentazione e degli stili di vita, rispetto a quello dell’inquinamento secondo la nota formula lanciata da un saggio pubblicato su “Teh Lancet” nel 2006, della “pandemia silenziosa”, indotta dai micro inquinati chimici ormai compenetrati in ogni matrice ambientale e quindi anche nell’organismo umano, perfino nel feto ancor prima della nascita. Certo, ragionando realisticamente sulle possibilità della prevenzione, una corretta alimentazione potrebbe essere più facilmente conseguibile, rispetto all’eliminazione degli inquinanti chimici dalla biosfera e dai sistemi produttivi. Quest’ultima ipotesi richiederebbe un cambio di paradigma e di sistema molto impegnativo.
Lo steso schema si ripropone a p. 105 dove ci si sofferma su alcuni recenti casi controversi a proposito della cancerogenicità di alcune sostanze e si fa l’esempio del glifosate della Monsanto e della carne rossa insaccata. Dopodiché si approfondisce solo il caso della carne rossa e si tralascia quello del glifosate molto più spinoso su diversi versanti (contraddittorietà delle valutazioni scientifiche coinvolte in conflitti di interesse, colossali profitti della Monsanto, ora Bayer, minacciati da class action di risarcimenti veramente importanti).
Com’è evidente, si intendono affermare molte idee giuste senza travalicare un certo limite che gli autori sembra si siano concordemente assegnati.
Da segnalare il caso clamoroso della “rivoluzione verde” in agricoltura associata infelicemente, in termini di benefici per l’umanità, ai vaccini: “Per quanto riguarda la rivoluzione verde lanciata dall’agronomo e premio Nobel americano Norman Borlaug negli anni Sessanta, la diffusione di varietà geneticamente selezionate di grano resistenti alle malattie ha consentito in Paesi come India, Pakistan e Messico un’elevata produttività, che ha sottratto alla morte per fame centinaia di milioni di persone, forse persino un miliardo. Insomma, se consideriamo le vaccinazioni e la rivoluzione verde il saldo tra rischi e benefici è fortemente in attivo, un fatto che non dobbiamo dimenticare” (p. 6).
Se per quanto riguarda i vaccini, in particolare per vaiolo, polio, difterite e morbillo, sembra assodato che dopo gli anni Sessanta-Settanta dello scorso secolo si siano “risparmiati milioni di casi …ogni anno, molti dei quali mortali”, francamente più controversa è la valutazione sulla cosiddetta “rivoluzione verde”. Se si fosse trattato solo di “diffusione di varietà geneticamente selezionate di grano resistenti alle malattie”, il premio Nobel si sarebbe dovuto assegnare molto prima all’italiano Nazareno Strampelli, che negli anni Venti e Trenta seppe selezionare “sementi elette” ibridando e incrociando varietà diverse, con l’obiettivo di sconfiggere le tre principali calamità: la “ruggine bruna”, con sementi resistenti al fungo; l’allettamento, ovvero l’abbattimento al suolo causato dalle intemperie, riducendo l’altezza del frumento; la “stretta”, ovvero un rattrappimento del chicco provocato in fase di maturazione dalla siccità estiva, ottenendo grani precoci, che permettevano anche di intercalare altre colture, prima della successiva semina, con un aumento della produttività naturale di circa il 30% (S. Salvi, L’uomo che voleva nutrire il mondo. I primi 150 anni di Nazareno Strampelli, Accademia georgica Treia, Treia-MC 2016). Fu il vero artefice della “battaglia del grano”, purtroppo celebrata dal regime, che per questo gli avrebbe portato male per le sue possibilità di aspirare al Nobel, nonostante le sue apprezzate sementi avessero fatto il giro del mondo ed oggi siano celebrate dall’agricoltura biologica (famoso il grano “senatore Cappelli”). Ma la “rivoluzione verde” fu ben altra cosa: ha certo sfamato buona parte dell’umanità, evitando, secondo alcuni studiosi, la terza guerra mondiale, ma ad un prezzo altissimo. Ed è curioso che un pool di scienziati di così alto livello ignorino che “l’incremento delle rese è stato possibile con la selezione di ibridi più adatti all’agricoltura meccanizzata e in grado di sfruttare al meglio i fertilizzanti. Ciò ha portato alla necessità di utilizzare più petrolio per la produzione. L’uso continuo dei fertilizzanti, inoltre, ha prodotto diversi problemi di inquinamento, che insieme all’eccessivo sfruttamento del suolo e alla riduzione delle falde acquifere, stanno minacciando vaste estensioni agricole diminuendo le rese” (https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-verde_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/). Insomma il nostro compito è oggi quello di liberarci dalle trappole della “rivoluzione verde”, tornare ai metodi di un’agricoltura naturale, quella di Nazareno Strampelli e dell’altro illustre italiano, pioniere della bioagricoltura, Alfonso Draghetti, (A. Berton, Alfonso Draghetti (1888-1960): le radici dimenticate (ma molto attuali) del movimento biologico in Italia, in “Altronovecento.Ambiente Tecnica Società”, n. 28, febbraio 2016. http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/articolo.aspx?id_articolo=28&tipo_articolo=d_persone&id=131), ovviamente con l’aggiunta di tutta l’innovazione prodotta dalla buona ricerca e dalle buone pratiche in questi decenni. C’è da chiedersi, per tornare al testo che si sta commentando, se gli autori si siano accorti dell’autogol. Perché i casi sono due: o sanno che la “rivoluzione verde “ è un passato che va comunque superato, ma allora anche i vaccini lo sarebbero e dovrebbero dare ragione ai NoVax; oppure pensano che la “rivoluzione verde” sia il destino dell’agricoltura futura, magari rinforzata dagli Ogm, e che quindi l’abbandono dei fossili sia tutta una finzione. Sarebbe interessante sapere come effettivamente la pensa in particolare chi ha in mano le redini della cosiddetta “transizione ecologica”.
A questo proposito un altro tema, molto scottante e di attualità, va segnalato: come, appunto, si intende o si può fuoriuscire dai fossili. Si citano i casi dei piani energetici inglesi e tedeschi, constatando che “non sono molti i governi che stanno prendendo sul serio -cioè sistematicamente- i problemi energetici” (p.99). Quindi sempre sull’onda della complessità irriducibile di questi si fa notare che tendenzialmente chi è più avanti, come la Germania, “applica le soluzioni già esistenti (solare, eolico, maree) nella consapevolezza che nessuna di queste sia risolutiva, e anzi esse pongono problemi nuovi, come l’occupazione del suolo che compromette l’ambiente e le specie animali e vegetali” (p. 100). Ma. anche di fronte a questo limite, l’unica ipotesi che viene presa in considerazione è quella del rilancio tecnologico, ovvero di continuare a utilizzare i fossili catturando l’anidride carbonica. Di questa tecnologia, data come intrinsecamente sicura, vengono, però, giustamente evidenziati i limiti, perché le combustioni non provocano solo gas serra, ma anche smog inquinante dannoso alla salute. Osservazione da sottoscrivere e che dovrebbe consigliare comunque cautela nell’applicazione di questa tecnologia. Ma attenzione, questi percorsi richiedono comunque tempi lunghi di attuazione. Ed ecco le conclusioni spiazzanti: “Il ragionamento fin qui svolto ci sembra coerente e convincente, ma ha un grave limite: può essere troppo tardi per metterlo in pratica. Se è vero che il cambiamento climatico sta avanzando più rapidamente di quanto i modelli matematici avessero previsto, allora non basta più ridurre o azzerare le emissioni di CO2. Può essere necessario un immediato e intensivo investimento tecnologico nell’assorbimento di COz, una sorta di «progetto Manhattan», o la rivalutazione di tecnologie cadute in disgrazia come il nucleare. Se cosi è, si tratta dell’ulteriore prova del fatto che le soluzioni arrivano spesso troppo tardi – in questo caso portandoci sull’orlo di una catastrofe” (p. 110).
Che dire? Da un canto si lancia la sfida anche ai movimenti ambientalisti che troppo spesso si convincono di avere la soluzione, solo perché hanno le idee chiare su come si può da subito rendere autosufficiente con la sola energia solare un’abitazione civile, ma non hanno una minima idea, ad esempio, di come poter fare a meno del tutto dei fossili e nello stesso tempo continuare a godere di quel PC con cui elaborano i progetti (come alimentare il ciclo di vita e di funzionamento, input di materiali più o meno rari e output di rifiuti, della colossale componente dura, dal supporto personale a quelli regionali ed infine alle infrastrutture e impiantistiche globali).
Dall’altro, e questo è il buco nero di questo saggio, si prescinde dai limiti naturali della nostra presenza sul Pianeta. Il punto più rilevante dell’epoca dei fossili è che questo enorme tesoro di materia ed energia, accumulatasi in milioni di anni, ci ha illuso di non avere più limiti alla nostra crescita economica, e quindi di poter espandere la tecnosfera a prescindere dalle capacità rigenerative della biosfera. E’ vero che affidarsi interamente all’energia solare pone il problema degli spazi naturali, quelli rimasti da tutelare. Non solo per la salvaguardia della biodiversità, ma anche per poter alimentare tutti con un’agricoltura non più drogata dai fossili o, ad esempio, per poter produrre vegetali necessari alla biochimica, supposto che far a meno del tutto della plastica o di fibre sintetiche sembra molto difficile (si pensi solo al sistema sanitario…).
Questa è la stretta che non si vuole mettere a tema: che significa optare per una necessaria decrescita economica in particolare nei Paesi sviluppati, ma anche riprendere il problema demografico, come in solitudine continua a proporre Luca Mercalli. L’alternativa, occorre saperlo, è lo stoccaggio della CO2 ed il nucleare. Che sia Cingolani a ricordarcelo appare un tantino preoccupante.
In ogni caso qualche dubbio rimane che possa essere la tecnopolitica capace di risolvere i debiti secolari che ci angustiano.