“L’acciaio in fumo”
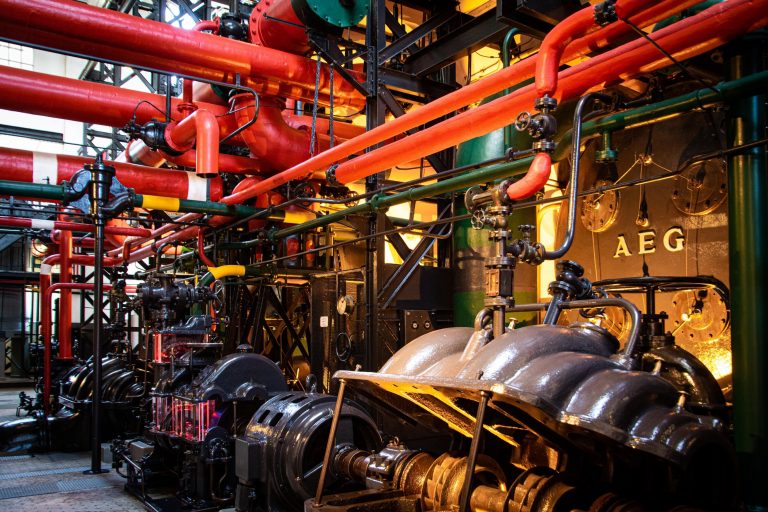
Salvatore Romeo, L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 ad oggi, Donzelli, Roma 2019, pp. 290
L’Ilva di Taranto come paradigma dell’industrializzazione nazionale nella seconda metà del Novecento. E’ questo, a me pare, il maggior pregio del lavoro pluriennale di ricerca compiuto da Salvatore Romeo e condensato nel suo L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 ad oggi, Donzelli, Roma 2019.
Romeo parla del territorio tarantino e di come questo è stato trasformato e stravolto dall’insediamento della grande acciaieria, ma in controluce potremmo leggere la vicenda della transizione da paese agricolo a quinta potenza industriale dell’Italia intera e degli stravolgimenti indotti sul nostro territorio e sull’ambiente in particolare nella seconda metà del Novecento.
Taranto, peraltro, era già, durante il ventennio, una della poche aree del Sud con una presenza industriale significativa, centrata sull’Arsenale ed il porto militare e sui cantieri navali, sicché godeva di una condizione di quasi piena occupazione. Con la fine della guerra ed il crollo del fascismo, si trovò, dunque, in una situazione di drammatica crisi, ancor più acuta che nel resto del Paese. Si usciva in modo traumatico da un sistema di economia di guerra, sostanzialmente protezionistico: dunque non solo crollavano le commesse militari, ma la conversione a produzioni di pace, nel caso dei cantieri, a naviglio commerciale, avveniva necessariamente in una condizione di inedita concorrenza internazionale, in un quadro di libero mercato imposto dal nuovo contesto internazionale in cui si veniva collocando il Paese.
Per Taranto, come per gran parte per l’Italia, significava affrontare una sfida cruciale, ben rappresentata dal titolo del primo capitolo del testo di Romeo: Taranto non vuole morire. Quella fase, passata alla storia come Ricostruzione, fu particolarmente travagliata per Taranto alle prese con un’insufficiente produttività ed un’inadeguatezza strutturale della tecniche produttive dei propri cantieri e quindi con reiterati tentativi e conseguenti insuccessi nel rilancio di una impresa la cui sopravvivenza, ancorché ridimensionata, fu possibile grazie a finanziamenti pubblici e con il decisivo intervento dell’Iri. Riecheggia, quindi, nella vicenda di Taranto il dibattito molto acceso e controverso in quegli anni sul ruolo dell’intervento dello Stato nell’economia. L’Italia aveva ereditato dal Ventennio alcuni colossi industriali pubblici come l’Agip in campo energetico e l’Iri presente nei settori delle telecomunicazioni, del trasporto marittimo, della siderurgia, della meccanica, della cantieristica e della produzione elettrica. L’ipotesi, inizialmente ventilata, di liquidare questa eredità venne rapidamente accantonata, essendo tutti consapevoli che la struttura industriale dell’Italia, sconvolta dalla guerra e ancora troppo fragile, non sarebbe stata in grado di riconvertirsi e ripartire senza un forte intervento dello Stato. Semmai il dibattito si sviluppò sui caratteri e la finalità di questo intervento: se dovesse limitarsi a supportare l’iniziativa privata e a soccorrere industrie in crisi o se dovesse intendersi come strumento operativo delle strategie di politica industriale deliberate dal Governo.
In qualche misura Taranto sperimenta ambedue le opzioni: la prima con il tentativo di salvataggio dei cantieri nell’immediato dopoguerra, e la seconda, a partire dagli anni Sessanta, con la creazione del grande centro siderurgico. Romeo ricostruisce minuziosamente il grande dibattito che precedette l’insediamento industriale destinato a cambiare profondamente il territorio tarantino. Un dibattito di straordinario interesse se confrontato ai balbettii delle classi dirigenti del secolo attuale del tutto incapaci a misurarsi con la crisi di quell’impianto tarantino e ancor più, in generale, con la lunga crisi economica dell’ultimo decennio.
Il grande meridionalista cattolico, Pasquale Saraceno, ampiamente citato da Romeo, fu il protagonista di quella “svolta” dell’Iri e della politica industriale del Paese. La vicenda del siderurgico di Taranto, ancora una volta, fu a questo riguardo emblematica. Di fronte alla ripesa economica della seconda metà degli anni Cinquanta “Saraceno prospettava per il gruppo pubblico una funzione di intervento in rapporto ai principali squilibri macroeconomici del Paese: in questo caso, la crescente scarsità di beni siderurgici (che metteva a rischio i conti con l’estero), da una parte, e il divario territoriale dall’altra”. Il disegno strategico di Saraceno era teso, da un canto, a porre basi solide allo sviluppo industriale del Paese e, dall’altro, ad unificarlo sul piano economico colmando il secolare divario tra Nord e Sud. La Cassa per il Mezzogiorno, da lui ideata, doveva essere lo strumento finanziario pubblico per perseguire questi obiettivi. E’, dunque, in questo contesto che nasce la proposta di un grande polo siderurgico dell’Iri-Finsider nel Meridione e segnatamente a Taranto, luogo ideale per l’infrastruttura portuale già esistente. Ovviamente, nelle intenzioni di Saraceno non doveva trattarsi, come altri interventi coevi nei settori della petrolchimica, di “cattedrale nel deserto”, ma diventare volano di un autosviluppo diversificato locale, oltre che supporto essenziale all’industria di base nazionale. Un sogno, che come mostra Romeo anche per il caso Taranto, incontrò grandi difficoltà a realizzarsi. Così tra il 9 luglio 1960, posa della prima pietra del grande cantiere, e il 20 novembre 1964, prima colata d’acciaio, in pieno “boom economico”, viene costruito il centro siderurgico tarantino. Una fase che il lavoro di Romeo ricostruisce correttamente andando oltre la dimensione della storia industriale, per diventare a tutto tondo storia dello sviluppo urbanistico di Taranto. Gli effetti di quel grande insediamento sul territorio furono rilevantissimi: colossali spostamenti di valore dei terreni; opere infrastrutturali di servizio; esplosione della rendita immobiliare per l’impennata occupazionale determinata immediatamente e temporaneamente dal cantiere e, poi, stabilmente dall’acciaieria; crescita caotica delle edificazioni per rispondere alla domanda di dimore. Insomma in pochi anni l’assetto urbanistico di Taranto fu sconvolto, lungo traiettorie in gran parte definite dalla speculazione e dal sistema di potere politico locale ad essa collegato. Ma verso la fine degli anni Sessanta nuove tendenze culturali si andavano affermando nei diversi ambiti sulla spinta di quel vasto movimento sociale che investì l’università e la fabbrica. L’urbanistica riscoprì il valore del territorio come bene pubblico da tutelare dagli assalti predatori della speculazione privata e anche a Taranto si discuteva di regolazione e di pianificazione. Un grande dibattito che sfociò nell’approvazione all’unanimità nel settembre 1974 della “variante”, ovvero di un nuovo indirizzo urbanistico le cui linee essenziali vale la pena richiamare, anche per segnare la distanza rispetto alla pochezza della strumentazione e prassi urbanistiche oggi vigenti in omaggio alla libertà dell’iniziativa privata.
La variante del ’74 “considerava imprescindibile stabilire un rapporto equilibrato fra città e campagna”, affinché anche l’agricoltura potesse avere un ruolo nel futuro assetto economico della città, riservando ad essa almeno il 50% del suolo comunale. Inoltre si prospettava uno sviluppo del porto commerciale autonomo e differenziato dallo scalo Finsider, al servizio di attività manifatturiere locali ma anche di produzioni di altri territori. Insomma, si trattava di ridefinire il rapporto con la grande industria in modo tale che “le istanze locali non avessero più una posizione subalterna”: un piano urbanistico, quindi, che non solo “aveva l’ambizione di indirizzare il tumultuoso processo di urbanizzazione che Taranto stava vivendo da oltre un decennio”, ma anche “prospettava una più ampia articolazione dell’economia ionica”. La gestione di quel piano fu ovviamente difficoltosa, ma rimane interessante il tentativo messo in campo per la prima volta di emancipare quel territorio dalla totale dipendenza dall’impianto siderurgico, tema tornato di bruciante attualità nell’ultimo travagliato decennio di crisi dell’Ilva privatizzata.
In quegli anni, mentre si ipotizzava e poi si realizzava il raddoppio della potenzialità produttiva, passando da 5,7 a 10,3 milioni di tonnellate l’anno di acciaio, emergeva per la prima volta il tema dell’impatto ambientale della grande fabbrica in un convegno promosso dall’Amministrazione provinciale il 27-28 aprile 1971, Inquinamento ambientale e salute pubblica, con relazione introduttiva e conclusioni affidate a Giorgio Nebbia. Da quel momento questo tema accompagnò l’esistenza del centro siderurgico con un andamento altalenante, imposto diverse volte dall’emergenza di associazioni e movimenti ecologisti, ma anche dall’iniziativa sindacale per la tutela della salute in fabbrica, e altrettante volte compresso dal ricatto occupazionale e dalla dipendenza di buona parte della città da quella fonte economica, nonché dalle strategie dell’imprenditore pubblico e ancor più di quello privato, i Riva, tese a minimizzare l’impatto delle emissioni inquinanti. Fino all’esplodere della crisi ambientale ed industriale degli ultimi anni di cui si dirà in conclusione.
Il nuovo decennio è di grande interesse anche perché, al suo esordio, nel 1970, si decise sia il raddoppio di Taranto, sia l’insediamento di un quinto centro siderurgico a Gioia Tauro, in Calabria. Le previsioni di un proseguimento dei ritmi di crescita del consumo dell’acciaio, analoghi a quelli del decennio precedente, che si erano attestati su un +9% annuo, risultarono ben presto del tutto errate, sia per la brusca frenata dell’economia mondiale indotta dall’oil shock del 1973-74, sia perché il boom economico si era ormai del tutto esaurito, per la semplice ragione che quella fase rispondeva alla condizione di un Paese arretrato in cui le famiglie per la prima volta accedevano ai beni di consumo durevole (frigorifero, lavatrice, televisione, automobile…), situazione, ovviamente, non più ripetibile. Così il quinto centro siderurgico non venne costruito e anche il colossale impianto di Taranto entrò ben presto in affanno. E’ singolare come ancora oggi questa distorsione indotta dal mito del “miracolo economico” agisca nei sogni (deliri?) dei politici italiani, da Prodi a Berlusconi, da Monti a Di Maio, pronti ad evocare un nuovo boom di fronte da un impercettibile auspicato aumento del Pil ed a scannarsi in nome del mito della crescita, obiettivo esclusivo ed unificante delle attuali politiche governative, peraltro sempre irraggiungibile.
Ma tornando agli anni Settanta e a Taranto, la politica delle quote inaugurata dalla Comunità europea per ridurre la produzione di acciaio esasperò la competizione tra i diversi produttori, mentre le più rigide politiche monetarie della Banca d’Italia finalizzate all’ingresso nel futuro Sme (serpente monetario europeo, temporanea transizione verso l’euro) aumentarono gli oneri finanziari ed i costi di ammortamento indotti dal raddoppio. Tutto ciò, insieme ad altri fattori locali, ridusse la competitività dell’impianto di Taranto destinato ad avvitarsi in successivi esercizi sempre più in perdita. Gli anni Ottanta, segnati dal trionfo del neoliberismo, della deregolazione tesa a sgravare l’iniziativa privata dai “lacci e laccioli” dell’intervento statale, spingono, con una convergenza politica pressoché unanime, alla privatizzazione delle industrie pubbliche. Gli inizi del nuovo decennio portarono con sé anche una drastica recessione con un pesante calo dei consumi di acciaio che penalizzarono ulteriormente il polo di Taranto, già in difficoltà, che peraltro non poteva più godere degli aiuti di Stato, come in precedenza, a causa delle norme europee a tutela della concorrenza. In questo quadro la gestione di Prodi dell’Iri si propose, all’interno di una complessiva ristrutturazione dell’Istituto, la liquidazione della Finsider, che a Taranto si realizzò il 1° gennaio del 1989 con la creazione di una nuova società, l’Ilva, esplicitamente finalizzata a traghettare gli impianti siderurgici, in particolare di Taranto, verso la successiva privatizzazione, che sarebbe avvenuta con i Riva sei anni dopo. La nuova Ilva dei Riva esasperò traumaticamente le politiche già avviate nella gestione del personale dall’imprenditore pubblico nel decennio precedente: riduzione drastica dei dipendenti, in particolare degli indiretti (dirigenti, quadri e impiegati); aumento della produttività del lavoro e quindi dello sfruttamento con un’organizzazione centralizzata e gerarchica che escludeva ogni contrattazione con il sindacato, costretto ad un ruolo sempre più residuale; rigida disciplina in fabbrica ed emarginazione in “reparti confino” degli operai riluttanti. Se a ciò si aggiunge il continuo rinvio dei necessari investimenti per attenuare l’impatto ambientale si può comprendere come i Riva avessero conseguito una significativa redditività dell’impianto. Le vacche grasse per i Riva durarono finché la questione ambientale, per troppo tempo compressa, esplose dirompente nel 2012, travolgendo gli stessi imprenditori privati e costringendo lo Stato a farsi carico di un lascito disastrato ed estremamente oneroso. Di nuovo il caso Ilva è particolarmente emblematico di quel processo di privatizzazioni delle fine del secolo scorso, spesso affrettato e dissennato, che meriterebbe uno studio critico sui risultati effettivamente conseguiti. E, per l’Ilva, siamo all’oggi ed al difficile, contrastato e controverso passaggio, dopo anni di gestione commissariale nei fatti pubblica, ad un nuovo gruppo imprenditoriale privato.
Romeo ricostruisce minuziosamente le tappe del lungo assedio ai Riva sia da parte delle strutture pubbliche deputate ai controlli ambientali e della Magistratura diverse volte intervenuta a supporto, sia ad opera dell’incessante e incalzante iniziativa di numerose associazioni ambientaliste del territorio, da Legambiente a Peacelink, alla più recente Cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Ma Romeo ricorda anche le tecniche sofisticate, compresa una capillare e puntuale azione di controllo sui media locali, messe in campo dall’azienda per reggere all’assedio senza essere costretta a investire risorse per la riduzione delle emissioni inquinanti. Com’è noto la situazione cominciò a diventare insostenibile per diversi e convergenti fattori: la nomina nel 2006 di un nuovo direttore dell’Arpa Puglia, Giorgio Assennato, molto competente, già docente universitario di Medicina del lavoro e responsabile scientifico del registro tumori jonico-salentino, nonché geloso custode della propria indipendenza e di procedure rigorose nel perseguire le necessarie indagini ambientali; l’intraprendenza coraggiosa di Alessandro Marescotti, di Peacelink, che nel 2008 scoprì, commissionando in proprio le analisi, la presenza di diossine oltre i limiti in latte e prodotti caseari provenienti da pascoli situati nei dintorni della fabbrica; infine la magistratura, nella persona della Pm Patrizia Todisco che dispose perizie sia ambientali che sanitarie ad esperti competenti ed indipendenti in grado di supportare efficacemente l’ordinanza di sequestro senza facoltà d’uso di tutti gli impianti dell’area a caldo, emanata il 25 luglio 2012, segnando definitivamente il tramonto dell’era Riva.
A questo proposito, ci permettiamo l’unica osservazione critica al pregevole lavoro di Romeo: sarebbe stato utile un approfondimento del tema cruciale dell’impatto ambientale corredandolo con una descrizione tecnica essenziale dell’impiantistica, del suo funzionamento, delle sostanze in gioco, in entrata ed in uscita, e delle trasformazioni cui sono sottoposte con le relative puntuali emissioni. Certo, lo storico non può avere queste competenze, ma può essere aiutato nel suo lavoro da esperti di tecnologia, di impiantistica, di chimica, di tossicologia.
Anche perché la questione della cosiddetta “ambientalizzazione” dell’impianto resta ancora la grande incognita per il futuro dell’azienda. Ad un osservatore mediamente critico rimangono molti interrogativi a questo proposito. L’Ilva andrebbe salvata e rilanciata perché un Paese industrializzato come l’Italia non può privarsi di una grande acciaieria, dunque per la salvaguardarne la presunta italianità: ma le materie prime, minerale e carbone, sono interamente importate ed in futuro la stessa gestione apparterrebbe ad una multinazionale straniera, ArcelorMittal, con strategie che ovviamente prescindono del tutto dagli interessi nazionali. La stessa multinazionale, peraltro, è costretta a fare i conti con seri problemi di mercato in Europa e di competitività a livello internazionale in particolare rispetto alla Cina: è difficile comprendere come l’Ilva, collocata a distanze ragguardevoli dalle miniere di carbone e di minerale, possa reggere la concorrenza in un mercato drogato dall’acciaio cinese assistito dagli aiuti di Stato, se non puntando ancora una volta sui consueti rinvii degli investimenti ambientali. Ma le risposte a questi interrogativi non possiamo pretenderle da lavoro di Romeo, un’indagine storica rigorosa sul caso dell’Ilva di Taranto e dei rapporti con il territorio circostante, che ha anche il grande pregio di aiutarci nella comprensione più in generale dei caratteri dell’industrializzazione italiana del secolo scorso, dei suoi punti di forza, ma anche dei limiti strutturali che ancora pesano nelle odierne difficoltà.
Brescia, 22 maggio 2019