Un caso di greenwashing ormai classico: i Monsanto Papers (1998)
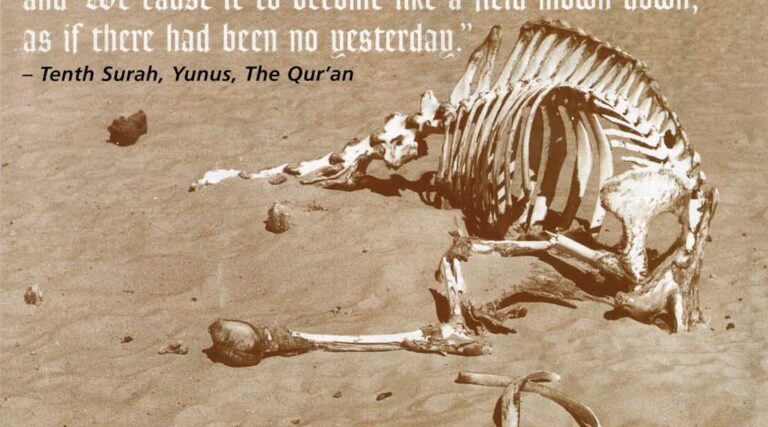
Il fallimento della strategia di pubbliche relazioni di Monsanto (Kenny Bruno)
La strategia di pubbliche relazioni di Monsanto consiste nel presentarsi come un’organizzazione filantropica interessata a proteggere l’ambiente naturale e a sfamare gli affamati del mondo. La realtà, tuttavia, non potrebbe essere più diversa.
“Monsanto ritiene che si debbano ascoltare tutte le opinioni” riguardo alle biotecnologie alimentari: così esordisce un’insolita campagna pubblicitaria europea della principale azienda statunitense di ingegneria genetica. Con l’aiuto dell’agenzia pubblicitaria inglese Bartle Bogle Hegarty, Monsanto, il gigante della chimica e dell’agroalimentare con sede a St. Louis, intende “incoraggiare una comprensione positiva della biotecnologia alimentare” in Europa.
In questa campagna, Monsanto non chiede di acquistare i suoi prodotti, gli annunci sono quasi tutti testuali e i copywriter provano ad adottare un tono illuminato e conciliante. Decine di annunci di altre multinazionali viste di solito in tv o sulla stampa televisive e di stampa indignano molto più di questi della Monsanto.
Tuttavia, alcuni lettori salteranno sulla sedia quando vedranno l’ultima riga degli annunci, un invito a visitare il sito web o a telefonare agli uffici dei critici più accesi di Monsanto: Greenpeace, Friends of the Earth e Food for Our Future. Questi gruppi di pressione hanno infatti delle posizioni sulla biotecnologia che mettono a rischio quella che è la linfa vitale di Monsanto: i prodotti geneticamente modificati.
Monsanto si dichiara orgogliosa dell’“importante contributo della campagna pubblicitaria al necessario dibattito pubblico”, ma a posteriori sembra che fosse solo questione di tempo prima che qualche intelligente pubblicitario comprendesse i vantaggi della strategia di annunciare il sito web e il numero di telefono dei critici della multinazionale.
Tutti conoscono tali critici cosicché gli annunci finiscono col suggerire il coinvolgimento consapevole di queste Ong in un “dibattito aperto” sui temi, mostrando oltrettutto un sereno, anche se soggettivo, interesse da parte dell’azienda per questi argomenti. Nike fa spesso riferimento sulla sua pagina web alle argomentazioni dei suoi critici riguardo allo sfruttamento del lavoro nelle proprie fabbriche, anche se con un tono più difensivo rispetto a Monsanto, e anche l’industria nucleare di recente ha usato questa tattica. Una tattica, insomma, che vedremo sempre più spesso all’opera man mano che le aziende cercheranno di apparire il più aperte possibile.
Ma cosa significa in realtà tutto questo? Che con informazioni più disponibili che mai, la multinazionale fin de siècle ha rinunciato alla lotta per il controllo dell’informazione? Che le imprese transnazionali del XXI secolo saranno così impegnate per la democrazia da avviare volontariamente un controllo pubblico delle loro operazioni?
Il “responsabile dell’informazione” di Monsanto per l’Europa afferma che l’azienda incoraggia il lettore a esplorare altri punti di vista, perché “l’argomento della sicurezza e dei benefici della biotecnologia è della massima importanza”. Ma se questo è vero, perché non ci sono annunci simili in Nord America? Cosa c’è davvero dietro la decisione di Monsanto di spendere soldi per sensibilizzare il pubblico sulle campagne dei suoi stessi critici?
La Monsanto ammette che si tratta di una reazione ai propri critici, accusati di diffondere disinformazione, teorie voodoo, vandalismo, oscurantismo e una dose permamente di storie allarmistiche sulle cosiddette “infestanti super-resistenti agli erbicidi” e sui “cibi-Frankenstein”. A parte la novità di indicare i contatti di Greenpeace, gli annunci si inseriscono chiaramente nella tradizione della pubblicità ambientale aziendale nota come greenwash.
Questo articolo analizzerà quindi la campagna pubblicitaria nel contesto della storia del greenwash e mostrerà come Monsanto abbia scelto uno specifico approccio per il mercato europeo a causa del fiasco di relazioni pubbliche che ha caratterizzato l’introduzione della soia geneticamente modificata in Europa nel 1997.
Il greenwash è stato concepito dopo le principali catastrofi ecologiche degli anni ’80: Love Canal, Bhopal, Chernobyl, Basilea, Exxon Valdez e il buco dell’ozono. Il posto di queste catastrofi nell’immaginario dell’opinione pubblica e il degrado ambientale globale che esse rappresentavano, divennero così grandi da minacciare la libertà di movimento e i profitti delle industrie che vi furono coinvolte: le normative ambientali proliferarono, i gruppi di pressione ambientalisti crebbero come mai prima e la protezione dell’ambiente divenne un tema enormemente popolare. Le aziende responsabili dei disastri furono additate alla riprovazione collettiva e a Monsanto, inventore di uno degli inquinanti più diffusi al mondo (i PCB), venne addossata una parte sostanziale della colpa. A questo punto le aziende furono costrette a fare qualcosa di diverso dalla tradizionale negazione di ogni responsabilità, strategia che fino a quel momento si era dimostrata efficace. Fu così che nacque la controstrategia costituita dal greenwash.
I pilastri del greenwash furono individuati nella pubblicità con immagini ambientali, nei codici volontari di condotta aziendale e nelle più tradizionali campagne politiche volte ad evitare l’adozione di normative stringenti ed efficaci. Negli Stati Uniti, DuPont (il principale produttore di sostanze chimiche che distruggono l’ozono) e Occidental Petroleum (il principale responsabile del disastro di Love Canal) hanno presentato pubblicità con immagini di balene, foche, uccelli e bellissime scene di oceano o foresta. Rhone Poulenc, Sandoz, Waste Management, Mitsubishi, Ford, General Motors e Union Carbide ne hanno seguito l’esempio. La multinazionale britannica ICI ha provato a fare pubblicità greenwash in Malesia (“Paraquat e natura in perfetta armonia”), mentre la Shell ha fotografato un’adorabile ragazza asiatica con in mano un mappamondo per una pubblicità sulla rivista dei Friends of the Earth di Hong Kong. Il tono era pio, premuroso, più-ambientalista-di-te. Con poche società di pubbliche relazioni al servizio di molte multinazioni, la pubblicità greenwash è diventata rapidamente un’industria globale.
Il secondo pilastro del greenwash sono stati i codici volontari di condotta aziendale. Negli Stati Uniti, Responsible Care – un codice per le aziende aderenti alla Chemical Manufacturers Association (CMA) – è diventato il programma ambientale di riferimento per l’industria chimica. Esso è stato rapidamente adottato dall’ European Chemical Industry Council e poi si è diffuso in America Latina e in Asia. Responsible Care è nato come risposta alla fuga di gas di Bhopal e ha ricevuto quindi impulso dallo sviluppo del codice di condotta elaborato all’interno della comunità degli investitori responsabili statunitensi. Al pari della pubblicità a contenuto ambientale Responsible Care non è stato un programma proattivo, bensì la reazione di un’industria spaventata. Membro di Responsible Care, Monsanto ha appreso in questo modo l’arte del Greenwash.
La posizione di Responsible Care ha rappresentato un affascinante esempio di equilibrismo, soprattutto perché la sua ambivalenza è stata costantemente replicata nelle politiche aziendali (compresa quella della Monsanto) in materia di ambiente e lavoro. Responsible Care aveva un doppio pubblico: l’opinione pubblica in generale e le stesse imprese. All’opinione pubblica veniva assicurato che l’industria riconosceva le sue preoccupazioni e che avrebbe fatto tutto il possibile per evitare i tipi di catastrofe che tutti temevano. Ma di fronte alla platea dei propri membri, gli ideatori di Responsible Care non potevano ammettere apertamente che l’industria nel suo complesso si era resa colpevole di gravi crimini ambientali. Così ammettevano solo che c’erano stati “troppi incidenti” e che l’industria non era riuscita a “comunicare” adeguatamente al pubblico. Il linguaggio utilizzato da Responsible Care – ad esempio lo slogan del “miglioramento continuo” – lascia aperta l’interpretazione se i miglioramenti delle prestazioni ambientali siano necessari per la salute del pianeta oppure se siano necessari soprattutto per salvare l’immagine pubblica delle imprese. Il messaggio misto è “non c’è nessun problema, ma siccome molti di voi pensano che ci sia, lo risolveremo comunque”, il che non è del tutto rassicurante.
Nel frattempo, queste stesse aziende e associazioni di categoria esercitavano pressioni contro l’adozione delle normative ambientali che miravano a risolvere i problemi posti dalle loro pratiche. In queste sedi le imprese sostenevano che Responsible Care e altri codici di condotta volontari rappresentavano un approccio più efficiente rispetto alla regolamentazione di tipo “comando e controllo”. Il messaggio, più o meno, era questo: “Noi siamo gli esperti, amiamo la natura e ce ne occupiamo noi. Se voi del governo vi immischiate non farete altro che rovinare tutto”.
Con il greenwash, le aziende più nocive dal punto di vista ambientale nei settori della chimica, dei rifiuti, dei combustibili fossili, dell’industria automobilistica e del nucleare si sono massicciamente appropriate di immagini e di slogan del movimento ambientalista per sviare le critiche alle loro pratiche. La Terra, la flora e fauna sono diventate le immagini più usate dalle aziende che avevano fatto di più per distruggerla. Le aziende si sono appropriate della Giornata della Terra, hanno appoggiato le pratiche di riciclaggio e hanno ridefinito a loro piacimento i modi per prevenire dell’inquinamento. L’“autoregolamentazione” ha fatto apparire come anacronistica la nuova legislazione ambientale.
Mentre le imprese hanno continuato a impegnarsi per indebolire o far naufragare le legislazioni ambientali a livello nazionale, le questioni ambientali sono diventate importanti anche a livello intergovernativo. Nel corso della preparazione della conferenza Onu di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992 il greenwash è diventato globale. In questo forum globale, l’industria ha operato attraverso il Business Council for Sustainable Development (BCSD) e la Camera di Commercio Internazionale per organizzare una campagna politica globale a beneficio dei propri membri (Monsanto, inclusa). L’obiettivo era quello di affermare un’immagine di sé come decisamente favorevole all’ambiente, assicurandosi al contempo che il vertice non si trasformasse in uno strumento di capace di esercitare un potere reale. La pratica dell’azione politica coordinata a livello globale da parte dell’industria è diventata più evidente nel periodo precedente alla riunione della Convenzione sul clima di Kyoto dello scorso anno, quando la Global Climate Coalition e la US Business Roundtable hanno lanciato campagne multimilionarie contro il trattato sul clima. Ma i precedenti sforzi delle imprese in occasione della conferenza di Rio sono stati più sfumati e hanno dato l’impressione che le imprese fossero a favore del vertice e che anzi stessero contribuendo alla sua realizzazione.
Nella maggior parte dei casi questi sforzi hanno avuto successo: il segretario generale della conferenza di Rio Maurice Strong ha pubblicamente lodato gli sforzi dell’industria, i documenti della conferenza non hanno tentato di porre limiti alle azioni delle multinazionali e inoltre l’impegno globale per l’applicazione dell’Agenda 21 è stato notoriamente carente. Alla sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la verifica quinquennale dell’applicazione delle risoluzioni prese a Rio (Ungass) ha mostrato che il processo adottato durante la conferenza era stato di fatto abbandonato. Il presidente del G-77 si è lamentato del fatto che l’agenda per lo sviluppo è stata messa da parte; i funzionari della Commissione per lo sviluppo sostenibile hanno adottato il linguaggio del Business Council, quello cioè della “cooperazione tecnologica”, e il presidente dell’Assemblea Generale, l’ambasciatore Razali della Malesia, ha ospitato un pranzo a porte chiuse per gli amministratori delegati (CEO) delle grandi imprese consentendo la partecipazione di soli due rappresentanti delle ONG. Di fronte a tutto ciò c’è stato soltanto un flebile accenno di protesta.
Nei cinque anni trascorsi tra la conferenza di Rio e la sua revisione quinquennale le potenti corporazioni mondiali hanno perseguito senza pietà i loro obiettivi: libero commercio, investimenti liberalizzati e controllo sulla tecnologia. L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a differenza del vertice di Rio, ha potuto operare incisivamente senza dover affrontare una significativa partecipazione pubblica. Le multinazionali hanno riconosciuto a parole l’importanza di Rio ma hanno fatto in modo che fosse l’OMC e non le Nazioni Unite a controllare i processi fondamentali della globalizzazione.
Dopo Rio sviluppo sostenibile e questione ambientale si sono intrecciate. Questa “empia alleanza” – come l’ha definita Wolfgang Sachs – ha portato a una maggiore comprensione nella comunità internazionale del rapporto tra ambiente e sviluppo, soprattutto per quanto il Sud del mondo ma ha anche fatto il gioco delle multinazionali, che hanno potuto inserire praticamente qualsiasi progetto o pratica con implicazioni economiche sotto l’ombrello dello sviluppo sostenibile.
Riverniciare di verde le biotecnologie
È esattamente nella cornice dello sviluppo sostenibile che Monsanto posiziona le sue colture geneticamente modificate. In un momento in cui persino i diplomatici delle Nazioni Unite si sono stancati della retorica dello sviluppo sostenibile, aziende come la Monsanto hanno aumentato l’uso di questa espressione per descrivere le loro attività. Come azienda leader nel settore delle biotecnologie, Monsanto vorrebbe farci credere di essere anche leader dello sviluppo sostenibile. E nel promuovere questa visione utilizza le tecniche del greenwash.
L’amministratore delegato di Monsanto, Robert Shapiro, è un praticante devoto dello stadio “sviluppo sostenibile” del greenwash. In questa fase le preoccupazioni ambientali restano ancora importanti, ma è la sostenibilità la pietra angolare. Nella Environmental Review di Monsanto del 1996, Shapiro scrive: “Lo sviluppo sostenibile avrà un posto di primo piano in tutto ciò che faremo”. La formulazione è perfetta: agli addetti ai lavori e alle agenzie di pubbliche relazioni, Shapiro sta dicendo che enfatizzerà gli aspetti dello sviluppo sostenibile in tutto ciò che fa. Per il grande pubblico, invece, Shapiro sta dicendo invece che l’azienda diventerà un’azienda effettivamente dedicata allo sviluppo sostenibile. Tornando al lato commerciale dei rapporti annuali dell’azienda, Shapiro chiarisce che l’azienda si dedica all’ingegneria genetica. La sua frase con cui indica questa specializzazione è un classico esempio di greenspeak, di riverniciatura verde del linguaggio: “colture geneticamente migliorate”.
Quando la Monsanto ha introdotto negli Stati Uniti colture geneticamente “migliorate”, non c’è stata nessuna fanfara, nessuna campagna pubblicitaria, nessun invito a “sentire tutte le opinioni”. In effetti la Monsanto ha fatto di tutto per evitare il dibattito sui suoi prodotti transgenici, soprattutto combattendo l’adozione di obblighi di informazione in etichetta. Il Posilac, l’ormone ricombinante della crescita bovina (rBGH) della Monsanto, è stato introdotto negli Stati Uniti nonostante le strenue obiezioni dei consumatori e dei sostenitori dell’agricoltura contadina. Monsanto ha minacciato di fare causa agli Stati che volevano etichettare i prodotti lattiero-caseari privi di rBGH. Come ha osservato di recente il “New York Times”, “poiché la maggior parte dei consumatori non è consapevole della quantità di alimenti geneticamente modificati che sono disponibili … è difficile giudicare la loro resistenza a tali prodotti”. L’enorme vantaggio dell’ignoranza dei consumatori non è sfuggito alla Monsanto e l’opposizione all’etichettatura è diventata un elemento centrale della sua strategia di introduzione dei nuovi alimenti.
Così, quando negli Stati Uniti i semi di soia geneticamente modificati Roundup Ready (RRS) della Monsanto sono stati piantati per fini commerciali, non c’è stato alcun dibattito pubblico significativo sul fatto che per la prima volta tutti gli americani stavano praticamente per iniziare a mangiare ingredienti geneticamente modificati in centinaia di alimenti trasformati contenenti soia. Inotre la Monsanto si è opposta alla separazione della soia transgenica da quella convenzionale affermando che i consumatori non avevano bisogno di sapere se stavano mangiando Roundup Ready o meno “poiché non c’era alcuna differenza” tra questi e la soia normale. In altre parole, il pubblico non aveva il diritto di sapere e di scegliere se mangiare o meno latte, soia o altri alimenti geneticamente modificati. I principali commercianti di cereali, come Cargill e Archer Daniels Midland, sono stati d’accordo con Monsanto, così come le autorità di Washington. Nonostante proteste sparse la soia transgenica è stata piantata, raccolta e mescolata con le colture convenzionali e ora viene mangiata dalla maggior parte degli americani, ma solo una piccola percentuale di questi ultimi è a conoscenza di questo cambiamento fondamentale nella loro dieta quotidiana.
Quando è stato il momento di esportare la soia in Europa, che acquista circa il 25% del raccolto di soia degli Stati Uniti, la Monsanto ha mantenuto la sua posizione: nessuna separazione tra soia transgenica e non transgenica, nessuna etichettatura per la soia Rondup Ready, nessun diritto del pubblico di sapere. Il risultato, per l’azienda, è stato un clamooso fiasco di relazioni pubbliche. L’approvazione dell’UE era ancora in corso quando le prime spedizioni lasciarono gli Stati Uniti nell’autunno del 1997. La maggior parte dei consumatori europei fu colta completamente alla sprovvista: improvvisamente la loro dieta doveva contenere ingredienti geneticamente modificati! Non erano stati avvertiti e gli alimenti non sarebbero stati etichettati. Un’ondata di indignazione attraversò l’opinione pubblica, diversi Paesi e aziende iniziarono a cercare forniture di soia priva di RRS per rassicurare i consumatori e il mercato della soia fu gettato nel caos. L’arroganza della Monsanto, che presumeva che l’Europa avrebbe accettato la soia transgenica senza porsi domande, generò una tempesta politica attorno alla prosaica soia.
Ciò che continua a sconcertare e irritare Monsanto e altri sostenitori dell’ingegneria genetica è che la tempesta non si è placata. Essi vedono la resistenza europea all’ingegneria genetica come una “superstizione luddista” che va superata. “Si tratta soltanto un altro passo nella storia dell’agricoltura”, sostiene Joseph Zak dell’American Soybean Association, che sta cercando di promuovere l’accettazione europea della soia Roundup Ready di Monsanto.
L’attuale campagna pubblicitaria della Monsanto, insomma, si riesce a comprendere nel contesto della sua prima incursione nel mercato europeo degli alimenti geneticamente modificati. Il loro errore di calcolo – che il consumatore europeo avrebbe reagito come quello statunitense – è stato così monumentale che l’azienda non ha avuto altra scelta che tentare un approccio completamente diverso. Se il primo approccio è stato quello di tentare di impedire al pubblico di essere informato e consapevole, ora sostengono che “il cibo è così importante che tutti dovrebbero sapere tutto quello che vogliono su di esso”. Solo dopo il fiasco l’azienda si è convertita alla convinzione che “un approccio trasparente troverà il favore dei consumatori di tutto il mondo”. L’impegno recentemente assunto dalla Monsanto in favore del dialogo, della riduzione dell’uso dei pesticidi, del nutrire il mondo, è la reazione di un’azienda che si trova alle prese con un problema. Anche se sono infastiditi dal fatto di essere stati citati nelle pubblicità della multinazionale i suoi critici possono rincuorarsi perché queste pubblicità sono il sintomo che che i loro sforzi costituiscono una minaccia effettiva per la diffusione illimitata della biotecnologia alimentare. Come dice Doug Parr di Greenpeace UK: “Questi spot sono il segno di un’azienda che sta soccombendo in una dibattito pubblico”.
Tuttavia, Monsanto non deve essere sottovalutata. Il suo impegno nella biotecnologia alimentare è totale e la finanza è ottimista sul futuro dell’azienda. Monsanto ha persino scorporato le sue attività chimiche tradizionali, preferendo concentrarsi sulla biotecnologia come attività strategica. Se la biotecnologia alimentare dovesse andare in crisi, Monsanto ne seguirebbe la sorte. Di conseguenza Monsanto si è trovata nella necessità di elaborare argomentazioni convincenti per sostenere la tesi secondo cui la biotecnologia alimentare equivale allo sviluppo sostenibile e viceversa.
Il più pericoloso di questi argomenti è che l’ingegneria genetica sia la risposta ai problemi alimentari globali. Monsanto fa leva sui nostri sentimenti sottolineando la tensione tra la crescita della popolazione mondiale e l’approvvigionamento alimentare. Su “The Independent” si legge che “preoccuparsi della fame delle generazioni future non le sfamerà. A sfamarle saranno le biotecnologie alimentari”. Chi vorrebbe negare ai bambini poveri del mondo la possibilità di nutrirsi meglio e ai loro genitori la possibilità di mettere a cultura più agevolmente i loro terreni? Chi sarebbe così egoista da opporsi agli alimenti geneticamente modificati per quanto riguarda sé mentre questi potranno beneficiare i meno fortunati? Questa è una versione del greenwash fondata sul senso di colpa.
Ma le colture geneticamente modificate aiuteranno davvero a sfamare gli affamati? In teoria, è possibile che alcune piante transgeniche siano più nutrienti, viaggino meglio o producano migliori raccolti in climi rigidi. Ma da un lato ciò è ben diverso dal dire che questi alimenti contribuiranno a risolvere i problemi delle persone affamate e da un altro lato l’enfasi principale della Monsanto è stata sullo sviluppo di colture che non possono avere alcun ruolo nell’alimentazione delle masse impoverite del Terzo Mondo. Un’analisi dettagliata del rapporto tra l’ingegneria genetica e la fame nel mondo esula dallo scopo di questo articolo, ma un breve sguardo a pochi prodotti Monsanto mostra perché l’argomento dell’approvvigionamento alimentare è solo greenwash.
Ad esempio, l’rBGH della Monsanto è pensato per aumentare la produzione di latte. Ma negli Stati Uniti c’è già un eccesso di offerta di latte e il suo costo di utilizzo esclude che esso possa essere adottato dagli allevatori poveri del Terzo Mondo.
I semi di soia Roundup-Ready non sono progettati per aumentare la resa, anche se la loro facilità d’uso potrebbe consentire agli agricoltori di piantare più semi di soia in terreni marginali aumentando al contempo l’uso dell’erbicida Roundup, sempre della Monsanto. Questi semi di soia in più, tuttavia, non arriveranno alle bocche dei bambini affetti da carenza di proteine.
Gran parte dei semi di soia finisce in realtà in olio o diventa un ingrediente secondario in un’ampia varietà di alimenti trasformati che i contadini denutriti del Bangladesh o del Ciad non vedranno mai, la maggior parte del mais Yieldgard della Monsanto è destinato all’alimentazione animale e lo stesso vale per la colza, le barbabietole da zucchero, il cotone, il mais o le patate transgeniche della Monsanto: nessuno di questi prodotti è destinato a mettere del cibo in bocca a bambini affamati.
Lo sfruttamento da parte di Monsanto di un tema emotivo di questo tipo può però creare degli effetti indesiderati: i diplomatici di 24 Paesi africani hanno recentemente rilasciato una dichiarazione congiunta con le ONG in cui si oppongono “con forza al fatto che l’immagine dei poveri e degli affamati dei nostri Paesi venga utilizzata da gigantesche multinazionali per spingere una tecnologia che non è né sicura, né rispettosa dell’ambiente, né economicamente vantaggiosa per noi”.
Se le colture ad alta tecnologia e ad alto input di danaro non sono la soluzione per la fame nel mondo sono però funzionali al desiderio di Monsanto di avere un maggiore controllo sulla produzione alimentare. L’acquisto di aziende produttrici di sementi, i divieti contrattuali imposti agli agricoltori di redistribuire le sementi, l’opposizione alle aziende più piccole che cercano di evitare l’rBGH e il timore dell’etichettatura, parlano di un’azienda preoccupata di accrescere la nostra dipendenza da essa per quanto riguarda il nostro sostentamento di base.
Monsanto pensa che nel lungo periodo ci convertirà alle colture transgeniche. Immagino che i suoi dirigenti vedano l’opposizione europea come una battuta d’arresto temporanea che sarà inevitabilmente superata con l’avanzare del progresso e del profitto. La loro campagna pubblicitaria è necessaria per rimediare ai danni causati dall’arroganza degli ultimi anni, un piccolo prezzo da pagare considerando la posta in gioco.
Nella revisione ambientale del 1995, l’amministratore delegato di Monsanto Shapiro concludeva: “Nei 94 anni di storia di Monsanto ci sono stati momenti in cui noi, come altri, non eravamo consapevoli delle nostre azioni come avremmo dovuto. Questi momenti sono finiti da tempo”. I critici dell’ingegneria genetica chiedono a gran voce una revisione delle conclusioni di Shapiro. Magari, a conti fatti, potrebbe chiamarli ai loro numeri di telefono che ha messo nelle pubblicità dell’azienda.
Burson Marsteller: i professionisti delle pubbliche relazioni (Lucinda Labes)
Burson Marsteller (B-M) è la più grande società di pubbliche relazioni del mondo, che opera in oltre 60 uffici in 30 paesi diversi. È specializzata nelle “percezioni” di cui dicono con convinzione che “sono reali, colorano ciò che vediamo, ciò che crediamo e possono essere gestite per motivare il comportamento e per generare risultati aziendali positivi”.
Quando il gigante petrolifero statunitense Exxon ha causato la più devastante marea nera della storia, B-M è stata chiamata a ritoccare l’immagine appannata della società e quando la dittatura militare argentina aveva difficoltà ad attrarre investimenti stranieri, la B-M è stata ingaggiata per “migliorare l’immagine internazionale del Paese”, negli stessi anni durante i quali sono “scomparse” circa 35.000 persone. Alla fine la B-M era orgogliosa di sottolineare che “i fatti sono rimasti gli stessi, è cambiata solo la percezione”.
La percezione dovrà tuttavia cambiare parecchio se le aziende associate ad EuropaBio((EuropaBio è la più grande federazione imprenditoriale europea del settore biotecnologico, che rappresenta 540 aziende e 8 associazioni nazionali ed è stata formata dalla fusione nel 1996 tra i due sindacati europei più solidamente radicati nel settore delle biotecnologie. EuropaBio esercita un’influenza sia a livello delle decisioni politiche che a livello locale.)) dovranno recuperare i miliardi investiti nelle biotecnologie. Quando i prodotti geneticamente modificati sono arrivati per la prima volta sugli scaffali dei negozi negli Stati Uniti e nell’UE, si è scatenata infatti una tempesta di proteste e di azioni dirette che non hanno fatto che aumentare.
È qui che entra in gioco Burson Marsteller. Prima del primo congresso europeo sulla bioindustria – EuropaBio ‘97 (Amsterdam, 25-27 giugno) – B-M fu incaricata di redigere una proposta di strategia per ottenere un cambiamento nella “percezione” pubblica. Successivamente questo documento è stato fatto filtrare a Greenpeace, che lo ha reso pubblico.
A EuropaBio B-M ha consigliato di tenersi alla larga da qualsiasi forma di dibattito pubblico e in particolare da quelli che per l’industria sono i campi minati per eccellenza, cioè le “questioni riguardanti i rischi per l’ambiente e per la salute umana”. Il compito di persuadere i consumatori ad accettare i prodotti geneticamente modificati dovrebbe essere lasciato a “chi ha la responsabilità di creare la fiducia nel pubblico, cioè i politici e legislatori”.
L’industria deve piuttosto concentrarsi nella diffusione di storie e di simboli positivi, suscitando un messaggio di “speranza, soddisfazione, cura e autostima”. “I simboli – aggiunge B-M – “sono cruciali in politica perché si collegano alle emozioni e non alla logica”.
L’opinione pubblica dovrebbe essere convinta che i prodotti geneticamente modificati non sono semplicemente sicuri, ma “superiori dal punto di vista ambientale alle varietà di colture standard”.
B-M ha inoltre suggerito a EuropaBio di tenere i media lontani dalla conferenza sulla bioindustria del 1997. Di contro, è stato consigliato di fornire ai giornalisti il tipo di storie positive pronte per l’uso “che vogliamo davvero far circolare”. Tuttavia, a dispetto delle tattiche di pubbliche relazioni, Greenpeace ha avuto poche difficoltà ad arruffare le penne della federazione: prima ancora che la discussione avesse inizio, un camion di semi di soia è stato scaricato all’ingresso della conferenza. Come ha osservato a malincuore Peter Linton, direttore del Congresso sulla bioindustria: “Ora le televisioni di tutta Europa mostrano le immagini di un carico di fagioli fuori dalla conferenza di settore. Abbiamo perso un’occasione”.
Riusciranno personaggi del calibro di Burson Marsteller a salvare la faccia alle biotecnologie in Europa? Monsanto e altri investitori biotecnologici dovranno scommetterci.